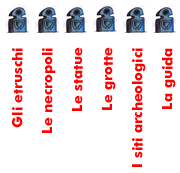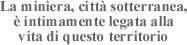
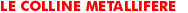


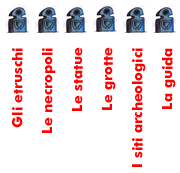
|
La miniera
è una città sotterranea, con vie principali,
piazze, slarghi, incroci, vie secondarie, vicoli ciechi. Le
gallerie principali, rivestite in muratura, alte, spaziose,
con parecchi binari, bene illuminate da impianti elettrici
fissi, corrispondono alle grandi arterie luminose e piene di
traffico,. le gallerie secondarie, strette, basse, a binario
unico, rivestite di modeste armature di legno, illuminate
solo dalla lampada del minatore, alle stradette di
periferia. "Queste suggestive parole, tratte da I
minatori della Maremma di Bianciardi e Cassola, pensate
per suggerire l'idea della complessità della
struttura fisica di una miniera, ci pare che possano
utilmente servire per capire quanto complesso sia scrivere,
anche, la storia delle attività minerarie del
territorio. La storia delle miniere, infatti, ha molte
implicazioni, e per tracciarla sono necessari apporti che
provengono da discipline diverse: la geologia e la
mineralogia, la storia della tecnologia, la storia sociale
ed economica. Anche da questa complessità
metodologica dipende il fatto che tale storia sia, in larga
misura, ancora da scrivere. Qui verranno accennate solo due
argomenti di storia mineraria, rimandando ad altre parti del
volume per un inquadramento più puntuale dello stato
delle conoscenze geo-mineralogiche e tecnologiche. Si
prenderanno dunque in esame i "segni" più visibili di
tali attività, che contraddistinguono la
conformazione visiva del paesaggio, e si parlerà
degli uomini che nelle miniere hanno lavorato:
I "segni" delle miniere: archeologia mineraria ed
industriale.
I segni delle attività minerarie sono numerosi e
facilmente individuabili per l'impronta lasciata sul
paesaggio. Nelle aree degli affioramenti minerari, il bosco
subisce agli occhi dell'osservatore una brusca interruzione.
Qua e la si aprono spazi circondati da piccole radure che
circoscrivono un'area sassosa color ruggine. Sono le antiche
discariche, segni di un'attività estrattiva che ha
trasformato il suolo, arricchendolo di sali che da secoli
impediscono lo sviluppo della vegetazione, anche di quella
vegetazione pioniera che riesce a colonizzare la sabbia e la
nuda roccia. Quasi sempre queste distese sono accompagnate
da un pozzo di estrazione. L'osservazione dei materiali
estratti mostra rocce dure che hanno costretto gli uomini a
servirsi di strategie che superassero i limiti posti alla
forza fisica e all'inadeguatezza degli strumenti. Osservando
queste rocce appare ovvia l'inutilità del più
semplice degli strumenti, il piccone. Tra l'altro il pozzo
ci mostra un ambiente angusto in cui i movimenti sono
limitati. Si ricorreva quindi al fuoco, riscaldando la
roccia e poi raffreddandola bruscamente con un getto
d'acqua, perchè si formassero crepe per poi lavorare
con cunei e scalpelli. L'area che meglio mostra questo
paesaggio e quella di Serrabottini e Montepozzali, nelle
vicinanze dei moderni impianti della miniera di Capanne.
Altri segni di attività si osservano nell'area a
Ovest della sorgente delle Venelle; altri storicamente molto
importanti sono nella zona di Cugnano. Ancora nel secolo
scorso nei pressi dell'abitato di Montieri era possibile
vedere discariche e pozzi. Altre miniere hanno lasciato le
proprie tracce nella valle del Merse sotto Boccheggiano.
Nelle vicinanze delle aree estrattive è sempre
possibile individuare i luoghi della lavorazione dei
prodotti del sottosuolo. Ampie distese di scorie
dall'aspetto vetroso segnalano i luoghi in cui sorgevano
queste antiche officine.
I minatori
Fino alla fine del secolo scorso i lavoratori delle miniere
erano una delle tante categorie stagionali presenti in
Maremma, poiché l'attività mineraria non era
stabile (molti erano i fallimenti) e soprattutto
perchè la malaria costringeva a interrompere i lavori
durante il periodo estivo. Il lavoro della miniera era
quindi molto spesso affiancato al lavoro agricolo. Quando si
consolidò l'industria estrattiva, alla fine
dell'Ottocento, i lavoratori delle miniere iniziarono ad
assumere un'identità professionale e una fisionomia
sociale nuove. La peculiarità dell' industria
estrattiva era dovuta sia alla mancanza delle innovazioni
tecnologiche che caratterizzavano in quel periodo altri
settori industriali, sia alle moltissime qualifiche
professionali presenti in miniera, cui corrispondevano
disparità di trattamenti salariali e normativi.
Questi ed altri fattori ostacolarono la nascita di
un'organizzazione sindacale di classe, che crebbe invece in
seno alla comunità di ciascun paese. Tra fine
Ottocento ed inizio Novecento i minatori organizzarono le
prime forme di lotta sindacale, organizzandosi in "leghe" e
ricorrendo all'arma dello sciopero; molti piccoli borghi
rurali si erano intanto trasformati in centri minerari,
punti di diffusione delle idee socialiste. Alla vigilia
della prima guerra mondiale i minatori si presentavano come
soggetto sociale e politico autonomo; dopo la guerra le
"leghe" grossetane, unite, riuscirono a elaborare un unico
documento di rivendicazioni sindacali. Con l'avvento del
fascismo iniziò la sistematica azione di distruzione
delle organizzazioni dei minatori. appoggiata dalle
società minerarie. Dopo il 1944 la ripresa produttiva
incontrò difficoltà notevoli. L'opera di
ricostruzione iniziò in un clima di collaborazione
anche se poi cominciarono a manifestarsi difficoltà
sempre più gravi nei rapporti tra direzioni e
maestranze. La prima significativa azione di lotta fu nel
1949; nei mesi successivi si susseguirono gli scioperi, fino
a giungere nel febbraio 1951 alla "lotta dei 5 mesi", la
manifestazione più emblematica del secondo dopoguerra
che tuttavia non portò i vantaggi sperati. Dopo gli
anni Sessanta, parallelamente al declino dell'industria
mineraria, vi e stato il progressivo ridimensionamento del
movimento dei minatori, fino alla sua naturale e definitiva
scomparsa. Ora le miniere della zona sono tutte chiuse. I
"segni" materiali e la memoria storica dei minatori stanno a
simboleggiare l'epilogo di una storia durata molti secoli, e
che ci sembra di buon augurio chiudere con un brano, tutto
orientato ad un futuro diverso, ancora tratto da I minatori
della Maremma: << Abbiamo visto i minatori, l'ultima
volta, a Massa, mentre partivano per la terza "gita", quella
di mezzanotte. Sostavano immobili nel breve spiazzo sotto
l'abside del Duomo, con il tascapane a tracollo, silenziosi,
severi e gravi in volto, come gente che consapevolmente va
incontro ogni giorno alla fatica ed al pericolo. Un nostro
giovane amico, il minatore Radi Livio, parlava con un
impiegato della cooperativa: <.<.Domani ti dò
il racconto. Battimelo a macchina: ce ne vogliono sette
copie, per il concorso.>>
<<Come, gli chiedemmo, scrivi anche racconti? >>
Era arrivato il pullman e gli operai si andavano radunando
lentamente. Radi ci strinse la mano: <<Si capisce che
scrivo racconti. Perche? Volete scrivere soltanto voi due ?
>>
|